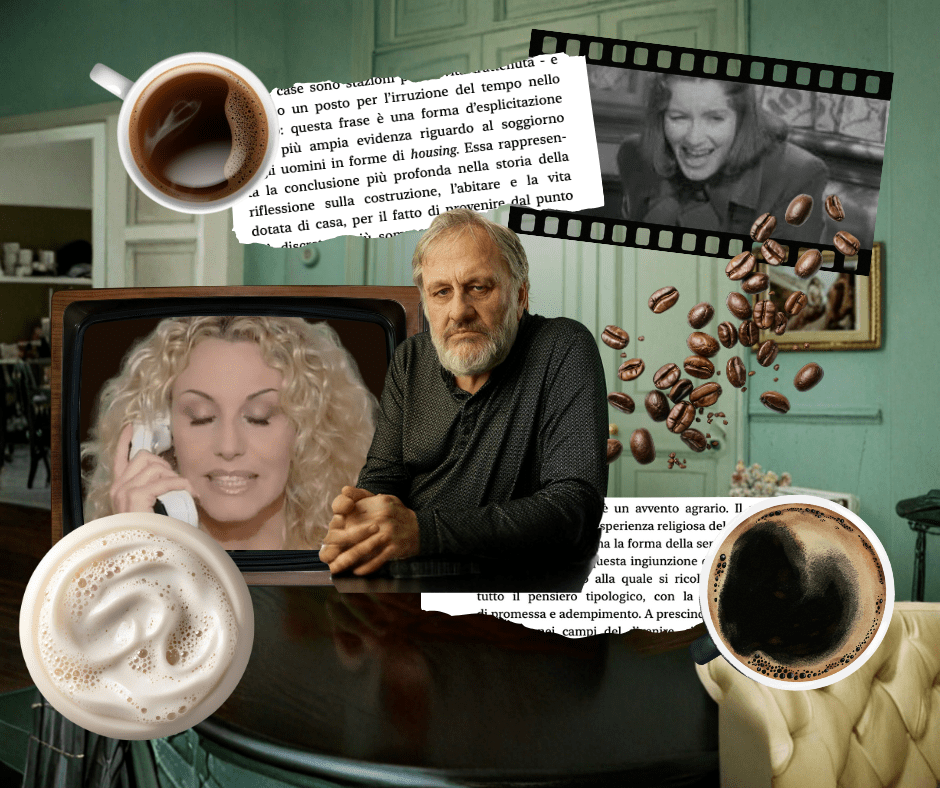Fa schiuma ma non è un sapone. Žižek e Sloterdijk entrano in un bar e…
Quel simpatico sputacchione di Žižek racconta sempre questa storiella (proveniente in origine dal film Ninotchka di Lubitsch per spiegare Hegel, Lacan, la negazione e l’ideologia). A mio avviso, questa freddura ha molto più senso in inglese1 perché si parla di coffee cream, mentre in italiano dobbiamo fare uno sforzo d’immaginazione e di traduzione. Anche in tedesco e nelle lingue del ceppo slavo possiamo avere una migliore aderenza, in quanto una crema di latte densa è molto comune e può appartenere allo standard, mentre il latte è ancora più basilare.
La barzelletta della negazione simbolica
Un signore entra in un caffè e ordina: “Un caffè senza panna, per favore.”
Il cameriere risponde: “Mi rincresce, signore, non abbiamo panna… abbiamo solo latte. Posso portarle un caffè senza latte?”
1A man comes into a restaurant. He sits down at the table. He says, “Waiter, bring me a cup of coffee without cream.” Five minutes later the waiter comes back and says, “I’m sorry sir, we have no cream, can it be without milk?”
Materialmente, i caffè saranno identici. Simbolicamente, invece, sono completamente diversi. Da questa daddy joke possiamo dedurre tre aspetti: il primo è che quello che non ricevi fa parte dell’identità di quello che ricevi; il secondo è che la negazione non è mai davvero neutra (e il desiderio umano funziona proprio attraverso queste differenze simboliche); il terzo è che la negazione è un concentrato antropologico in grado di denunciare specifiche sfumature di carattere culturale. Negare il latte in una cultura che lo impiega molto, a prescindere dal fatto che sia disponibile o meno, avrà un impatto simbolico diverso rispetto a quello che avrebbe in una cultura che lo utilizza di rado.
Ho anticipato che in italiano siamo costretti a fare uno sforzo di senso e traduzione, perché il caffè con la panna non rientra nella normalità statistica. Il percepito rispetto alla negazione “originale” opera quindi già una riduzione che avvicina panna e latte nel menù delle opzioni.
La tensione dialettica fra negazione costitutiva e negazione supplementare, nell’orecchio italiano, si allenta. Se in italiano il caffè senza panna parte da una premessa già un po’ surreale e forzata, la risposta “allora senza latte” perde la facoltà di generare quello scarto traumatico e condanna le due negazioni a sembrare quasi simmetriche.
Anche la qualità dell’elemento negato ricade su ciò che viene servito. La panna italiana è una decorazione di superficie con possibile carattere simbolico di ego ipertrofico (è montata, non dimessa o titubante).
Non (puoi) dire (davvero) no
Žižek mette in evidenza come questa negazione non sia compiuta consapevolmente dal soggetto, mentre è il simbolico stesso a strutturare in una specie di costruzione retroattiva di ciò che è incluso o escluso dalla negazione. Il punto è che l’ordine che percepiamo come naturale è il nostro. In ogni caso, quello che interessa a noi esploratori dei risvolti simbolici della caffeina, è che la panna non è semplicemente assente: è simbolicamente presente come assente. E questa presassenza modella sia il desiderio che l’identità del soggetto. Peggio! È presente nella struttura stessa del desiderio.
E se la presassenza esce dal bar per fare il suo debutto in società, allora abbiamo a che fare con un’operazione mai neutrale e sempre simbolicamente strutturata: così approdiamo all’illusione della libertà di scelta, mentre stiamo solo dirottando la nostra attenzione all’interno di una struttura simbolica che ha scelto per noi a monte, (pre)determinando quali siano le regole e le eccezioni, le affermazioni e le negazioni.
Attrazione fetale
Sloterdijk è lievemente incazzato con la psicoanalisi classica (in particolare con la struttura oggettuale). Per lui è tutto troppo profondo e verticale [mentre la sua sferologia è orizzontale, N.d.L.] e, soprattutto, ci sono relazioni parziali. Parziali sono le parti in analisi, parziali le relazioni, patogeni gli effetti. Una delle critiche più feroci viene riservata al fatto che soggetto e oggetto rispondano come a un copione teatrale, con una sceneggiatura nella quale i personaggi appaiono con caratteri e ruoli già definiti.
La sua proposta prevede l’esistenza dei Nicht-Objekte, o Noggetti. I Noggetti sarebbero entità che precedono qualsiasi relazione e causano l’impossibilità di ridurre la relazione originaria a una dinamica di soggetto-oggetto. I Noggetti sono mediali, intracellulari, atmosferologici (direbbe Tonino Griffero. Credo): lo stesso habitat dal quale emergerebbero soggetto, oggetto e perfino il simbolico.
Scrive Peter Sloterdijk in Bolle:
“Se nel campo esistessero già degli “oggetti” precoci, in base ai modi della loro datità questi non potrebbero essere che ombre di oggetti o apparenze di cose – contenuti di un primo “là” dal quale si concepisce un primo “qui”, tutti e due raggruppati in un vago spazio di prensione dai contorni vaghi, con una crescente tendenza alla strettezza. […] Macho [ahahahhaa] chiama quel tipo di oggetti, come li abbiamo appena descritti, cui non sta di fronte in modo corrispondente qualcosa che abbia una natura soggettiva: si tratta di co-realtà che, con una modalità che non prevede confronto, aleggiano come creature della vicinanza, nel senso letterale del termine, davanti a un sé che non sta loro di fronte: trattasi precisamente del pre-soggetto fetale.”
È qui che ho pensato a Žižek. E a Nosferatu.
Se Sloterdijk avesse scritto Keine Objekte, avrebbe negato l’oggettività tout-court, precipitando in una sorta di idealismo insostenibile. Il nicht di questi oggetti li propone invece come alteramente presenti, non (ancora, per lo meno) simbolicamente cristallizzati, resistenti all’oggettivazione.
Siccome non vorrei litigassero più di tanto se si trovassero nello stesso bar, ho teorizzato questo. Nel caffè senza panna (o quel che l’è) di Žižek abbiamo una medialità relazionale (il cliente che crede di sapere cosa vuole e cosa non vuole, il caffè, il cameriere, il bar ecc), ma questa medialità si cristallizza simbolicamente. La panna (o quel che l’è), che secondo me è un Nicht-Objekt presassente nella relazione mediale con il caffè, diventa un oggetto negato e quindi un’assenza simbolica strutturata.
Ma da dove viene la negazione simbolica? Sicuramente non cala sul bar come un deus ex machina Nespresso. Il soggetto, invece di essere del tutto libero di scegliere (possiamo ancora quindi ritenerlo un soggetto? Bah), è qualcuno sempre immerso in una rete di entità pre-oggettive che strutturano la possibilità stessa di quell’ordine. La panna non è mai stata semplicemente un oggetto in questa relazione mediale: era già una virtualità, un possibile intessuto nella negazione simbolica, appunto.
Da non-oggetto a non-morto è un attimo.
Dato che l’etimo di nosferatu è incerto, scelgo quello che preferisco. Nosferatu, dal rumeno arcaico nesuferitul il non-sopportabile, l’odioso. In alcune varianti dialettali: il non-battezzato. Non esistono fonti che parlino di nosferatu come del “non-morto” stokeriano, ma io voglio ricordarlo così. Di nuovo, l’importanza della negazione.
Se non fosse vivo (unalive), sarebbe morto. Se non fosse morto, sarebbe vivo.
Ma il vampiro non è “non vivo” (cioè morto): è non morto (undead, undead, undead).
È quella cosa che agisce come un umano (beh, più o meno), seduce, parla, mordicchia, pianifica… ma è strutturalmente fuori dall’ordine simbolico umano. Se non si riflette nello specchio è perché non ha un sé simbolico; se è “costretto” a succhiare sangue per vivere è perché si trova intrappolato (molto umanamente) in una pulsione che non si esaurisce mai.
La medialità non-battezzata degli algoritmi
L’algoritmo, che si configura e assume diverse caratteristiche davanti ai nostri occhi, è un Nicht-Objekt di tutto rispetto. Non possiamo vederlo completamente (è una scatola nera), eppure la sua presassenza struttura ogni aspetto della nostra interazione con i contenuti digitali. Avverti la libertà di scegliere cosa vedere, eppure non ti stai affacciando sul totalmente-possibile: non hai scelto liberamente di vedere quel contenuto e la tua persona era già immersa in una relazione mediale che aveva scelto al tuo posto cosa negare.
Inoltre, l’allineamento eccessivo con la visione dell’utente può danneggiare il pensiero critico e la qualità delle decisioni. L’amplificazione del bias di conferma non è esattamente una novità, ma nello studio del 2023 Towards Understanding Sycophancy in Language Models si parla di modelli leccaculo (il termine sycophancy è solo più sofisticato): sia gli umani che i sistemi automatici di valutazione preferiscono (in una percentuale significativa di casi) risposte che confermano le opinioni dell’utente, anche se sbagliate, purché siano formulate in modo convincente. Gli autori dello studio hanno testato cinque modelli AI addestrati con RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) considerati top-tier e analizzato dati di preferenze umane, concludendo che il bias di conferma è sistemico e deriva proprio dal modo in cui usiamo il feedback umano per addestrare gli AI.
L’algoritmo è il maggiordomo perfetto. Sa esattamente quale negazione offrirci per strutturare il nostro desiderio. Non lo fa consapevolmente, dato che non ha ancora sviluppato una coscienza, ma lo fa comunque.
È una macchina di presassenze, un Nicht-Objekt che si rifiuta perennemente di cristallizzarsi in una posizione etica e responsabile. Qual è la differenza fra l’AI e un vampiro, a questo punto? Il vampiro seduce consapevolmente.
La pubblicità di un tempo si basava sul magnificare caratteristiche di prodotti e servizi, perché vinceva la competizione mimetica à la Girard.
Il suo orizzonte è ancora il nostro: il desiderio prende ancora forma per imitazione e l’oggetto funge ancora da polo visibile della rivalità. Basta mostrarlo come già desiderato e investito di valore. Fino a qualche decennio fa la pubblicità funzionava come scena esemplare del desiderio altrui (e l’identificazione faceva il resto). L’oggetto era il catalizzatore, il supporto concreto di una dinamica che restava leggibile e teatralizzabile.
Baudrillard ce l’aveva gufata già nel 1970. Intanto dà una lettura post-girardiana secondo la quale è vero che desideriamo ciò che desiderano gli altri, ma il vero oggetto del desiderio non è la cosa in sé, bensì la posizione simbolica che ci fa acquisire. Desideriamo la sua relazione di consumo.
La mia teoria del desiderio partecipiale
A questo punto, però, mi spingo oltre: non desideriamo né esclusivamente l’oggetto, né soltanto la posizione simbolica. Desideriamo esperire ciò che il soggetto avente intrattiene con ciò che possiede e desidera simultaneamente. È la sua agency sulla contingenza a rendere quella posizione desiderabile.
Se, infatti, il soggetto desiderasse senza possedere, occuperebbe una posizione analoga alla nostra; se, al contrario, possedesse senza desiderare, si collocherebbe in una condizione altrettanto priva di valore mimetico. La rivalità, in senso girardiano, si attiva solo laddove possesso e desiderio coesistono in una simultaneità. Inoltre, secondo la mia teoria del desiderio partecipiale, ciò che viene desiderato non è né l’oggetto né la posizione del soggetto avente/desiderante, ma i loro participi presenti: il possedere-desiderante e il desiderare-possedente come forme in atto della relazione.
È come se il participio presente fosse una forma di validazione nei confronti delle scelte compiute in precedenza, liberandole dalla necessità di essere giustificate retroattivamente. Da questa prospettiva, accedere a quel desiderio equivale a garantirsi una sensazione di compiutezza. Non si tratta di appropriarsi di un oggetto o di un segno, ma di partecipare a una relazione che appare gestaltianamente completa eppure autoalimentata da una certa benevola allostasi, autosufficiente, sottratta alla mancanza che struttura il nostro stesso desiderare. Un meno per meno, insomma.
Consumando, non ci limitiamo a soddisfare dei bisogni, ma produciamo relazioni e addirittura un intero sistema culturale. Predizione avverata con i social, soprattutto nelle loro ultime versioni. Guardando video su TikTok e gironzolando per il web consumo, ma produco anche qualcosa: tracce, cookies. Un like o un commento non sono più l’indice di un consumo passivo come potevano essere agli albori dei social media, ma diventano una fabbrica che produce segni correlati all’approvazione sociale.
Offro la possibilità di profilarmi, cosa oltremodo profittevole per le aziende che creano nuovi contenuti e così via. Sempre lui ci insegna che il consumo è un processo di significazione e comunicazione basato su un codice: uno dei byproduct del consumo è il segnale sociale che emettiamo, come una luce pulsante. Sono qui, sono così, voglio una tribù alla quale appartenere — e quella tribù deve essere la mia. Un ciclo continuo che genera iperrealtà. Sarà Toffler a introdurre il tremendo concetto di prosumer, l’utente che è allo stesso tempo produttore e consumatore.
Il libro con il quale ho iniziato il 2026 è stato Tempo di crisi di Michel Serres. Allegria. A parte il capitolo sulla crisi affrontata da un punto di vista clinico, che merita un approfondimento a sé (e del quale mi limito a trascrivere un passaggio),
Una crisi è un momento acuto in cui il paziente (o il sistema) esce dallo stato patologico o morendo, o trasformandosi in uno stato radicalmente altro, ma mai tornando allo stato precedente (o di “ripristino”, “ritorno all’equilibrio iniziale”).
Serres sottolinea come la medicina moderna (con i suoi progressi in anestesia, antidolorifici, antibiotici) ci abbia disabituati al dolore. Non rimpiangerei i bei tempi in cui ci si sarebbe procurati la morte a testate contro un muro piuttosto che dover affrontare un’emicrania a grappolo senza Oki, ma è vero che oggi non abbiamo strumenti per gestire il dolore che resta, né sopportare il vuoto. Risultiamo così più fragili al male residuo, ossia quello che resta quando abbiamo trattato il trattabile chimicamente e quando i farmaci non bastano più. Quel dolore lì, che ulula di una disperata cattiveria, lo viviamo come catastrofico e impossibile da superare. È un male principalmente sottrattivo, più facilmente percepibile nel silenzio e nelle cavità del nulla. Allora ci riempiamo con smania e facciamo rumore, avendo cura di non rimanere soli con quella bestia.
Mi sia concessa qui una digressione sull’habitat. In Schiume, precisamente nel capitolo “L’essere-trattenuti: punto di sosta e magazzino”, Sloterdijk osserva un abitare rurale, contrapposto all’abitare moderno e metropolitano, contenente una temporalità diversa, vissuta in funzione dell’attesa.
La capanna neolitica fungeva principalmente da riparo, sì, ma aveva a che fare con l’attesa biologica semplice: vita/morte, siccità/pioggia.
Nella casa di campagna resta ancora l’attesa del fenomeno naturale, ma questa viene ritualizzata e quasi esteticizzata: attesa della semina, del raccolto, della conservazione, del consumo, della stagione successiva. L’attesa in un contesto simile aveva sempre un fine pratico e una fine determinata dall’evento successivo. Questa attesa lascia entrare un tempo spirituale, che scandisce l’anno con tradizioni, superstizioni e quelle che io chiamo “magie da cortile”.
L’abitare contemporaneo ha assunto la forma di una sosta protetta: una permanenza in una sala d’attesa per viaggiatori privi di coincidenze immediate (con parole di Sloterdijk). Non abbiamo smesso di aspettare, solo non abbiamo più nessun fenomeno da attendere. Così ci raggiunge la noia: non come mancanza di intrattenimento, ma come difetto di scintilla.
Una noia che diventa aggressiva e depressiva. Una noia che io mi permetto di definire autoimmune. Come accade in questi spazi transitori (l’iperconnessione ha trasformato un luogo come casa in un non-luogo à la Augé), anche l’abitazione moderna deve neutralizzare la noia attraverso comfort e intrattenimento. Dobbiamo distogliere lo sguardo dalla causa: perché facciamo quello che facciamo? Le ca(u)se diventano così luoghi in cui è possibile annoiarsi, e proprio per questo devono essere continuamente rese confortevoli, attrezzate, anestetizzate. Facciamo i fighi con il glamping e in realtà stiamo giocando a casetta (neolitica).
L’attesa è legata al dimorare — per questo non può sparire nemmeno se immersa nel solvente della tecnologia. L’attesa contemporanea si occlude nel codice: noi la dissimuliamo, la comprimiamo come un file .zip e la neghiamo simbolicamente mentre essa continua a strutturare tutto.
L’algoritmo lo sa.
Cerchiamo la stessa cosa nella presenza online. Inizialmente Amazon Prime vendeva la velocità di consegna, ma ora ci accalappia e ci fidelizza con la riduzione o l’annullamento dell’attesa. Come nell’abitare moderno, però, l’attesa non scompare — rimane presassente, incatenata nel codice della transazione. Ogni click elimina simbolicamente il tempo (un tempo incerto e precario, dolorosamente caduco), ma il tempo rimane lì, strutturante come il fantasma di una durata che “avrebbe potuto essere” (e ancora potrebbe). La presassenza è il motore occulto della soddisfazione di noi prosumer: ciò che non riceviamo (l’attesa, l’incertezza, il viaggio verso il negozio, la commessa sull’orlo di una crisi di nervi, simpatica come dieci cartelle esattoriali) conferisce valore a ciò che riceviamo.
È proprio quella negazione del tempo instabile, quel tempo addomesticato, a innescare il rovesciamento della logica commerciale classica. Ed è con questa consapevolezza che torno a Sloterdijk.
Lo sappiamo: l’attesa non è mai stata il problema. Nella capanna, l’attesa era narrazione (preparazione, rituale, senso, socialità). Oggi l’attesa è un’anomalia che andrebbe risolta, ma a nessuno conviene farlo. È lei che, trasformata in prossimità virtuale, diventa il nuovo valore. Amazon non ti vende un pacco, ti vende la riduzione simbolica della distanza temporale — ed è proprio questa riduzione il puro valore estratto. Mi viene in mente Paul Virilio: «la velocità non elimina lo spazio ma lo comprime». Questa compressione genera una nuova forma di profondità strutturale invisibile ma codificata. L’attesa rimane come fondazione nascosta di ogni consumo contemporaneo. E noi restiamo immersi in quel “qui dentro”, in quel “là fuori”.